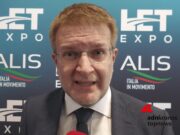(Adnkronos) – Esiste un’immagine iconica che racconta meglio di tutte le altre la strage di piazza Fontana. È una foto in bianco e nero, grandangolare, vecchia di quasi sessant’anni ma molto definita. È stata scattata dall’alto e riprende il grande salone circolare della Banca Nazionale dell’Agricoltura subito dopo lo scoppio della bomba. Sul pavimento ci sono centinaia di fogli di carta sparsi. E poi sedie distrutte, listelli di legno, imponenti schegge di vetro e lamine di metallo. Diversi uomini calpestano quel pavimento, sporco e devastato dai detriti. È la cristallizzazione di uno dei momenti più bui e dolorosi della storia del nostro Paese. È il 12 dicembre 1969. E da quel momento l’Italia, che aveva conosciuto la luce e la speranza col boom economico, non sarà più la stessa.
Paolo Dendena quel pomeriggio del 12 dicembre 1969 aveva soltanto dieci anni. Ma, a distanza di così tanto tempo, ha nella sua mente fissati i ricordi in modo lucido. Come se tutto fosse accaduto soltanto ieri. “Era la vigilia di Santa Lucia, ero a Lodi. All’epoca, Santa Lucia era una festa importante: era lei che portava i giocattoli in dono ai bambini, un po’ come accade oggi con Babbo Natale. Ero felice”. Suo padre, Pietro, era un commerciante di bestiame. Era nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana, a Milano, quel venerdì pomeriggio. “Era lì -dice all'Adnkronos- perché stava contrattando. All’epoca, quella era una vera e propria Borsa, tutti dalla Lombardia la frequentavano per comprare e vendere”. Paolo era nella casa dei nonni, perché la mamma e la sorella erano uscite per fare le compere nei mercatini in vista della festività. “Ricordo che, improvvisamente, arrivò in casa un vigile urbano del comando di Lodi. E ci disse che era successo a qualcosa di grosso, in centro a Milano”. Le prime informazioni parlavano dello scoppio di una caldaia. “E sembrava che mio papà fosse tra i feriti”. Il piccolo Paolo raggiunse subito, insieme ai nonni e agli zii, l’ospedale del Fatebenefratelli. “Arrivai lì e assistetti a uno scenario di guerra: lenzuola, barelle, corpi distesi sui letti, urla strazianti”. E poi il sangue. “Rosso, vivido, che invadeva e sporcava tutto. Un vero scenario di guerra”. La zia, che era da poco andata in pensione come infermiera in quello stesso ospedale, vide un medico. Lo riconobbe. “E chiese a lui di mio padre. Il dottore controllò la lista e lanciò uno sguardo. Da quegli occhi capii subito che mio papà era morto”. E la conferma della morte del padre arrivò pochissimo tempo dopo, da un piccolo dettaglio. “In fondo all’ospedale c’era una specie di ambulanza dove stavano caricando le barelle coi corpi. Riconobbi il tessuto della giacca di mio padre, un ‘principe di Galles’. Lo dissi a mia zia: quello era il ‘principe di Galles’ della giacca di mio padre”. Paolo, a soli dieci anni, si trovò di fronte a uno dei dolori più grande che un figlio può avere. Un evento traumatico per un ragazzino così piccolo. “Ricordo nei giorni successivi le fasi del riconoscimento dei corpi. Alcuni erano bruciati, altri dilaniati. I parenti non riuscivano a identificare i loro familiari”. Non era stata una caldaia. A sventrare la Banca nazionale dell’Agricoltura, in piazza Fontana a Milano in quel pomeriggio piovoso di quasi inverno, erano stati sette chili di tritolo, posizionati e minuziosamente nascosti sotto una delle scrivanie al centro dello spazioso salone. La conta finale dei morti fu agghiacciante. 17 vittime. E poi 88 feriti. Una ferita profondissima per la città di Milano e per l’Italia intera. I giorni seguenti furono quelli del lutto. Il 15 dicembre 1969 si svolsero i funerali in Duomo. “Ricordo la piazza, che era gremitissima. C’erano 300mila persone. Tutte in silenzio. Dalla massaia al dirigente, c’erano tutti. Perché tutti si chiedevano perché quella strage era accaduta. E a chi poteva giovare tutto quel sangue versato”. All’interno della grande navata centrale in stile gotico del Duomo, l’atmosfera era composta, solenne. “Per le esequie volevano avvolgere la bara di mio padre nel tricolore. Ma mia madre, insieme ad altre vedove, si oppose”. Un gesto forte. Ma motivato. “Rifiutò perché non era possibile andare in banca per lavoro e non tornare più a casa, la sera. Quello Stato, rappresentato da quella bandiera, non era stato in grado di proteggere mio padre”. Il protocollo prevedeva la presenza delle più alte cariche istituzionali. “Ricordo che aspettammo più di un’ora e mezza il presidente del Consiglio Mariano Rumor. Che si avvicinò a tutti i familiari delle vittime. Ma mia madre non volle stringergli la mano”. Il piccolo Paolo gironzolava intorno alla bara del padre quel giorno. “Rumor mi vide, mi fermò e mi fece una carezza. Col senno del poi, riconobbi fastidio in quel gesto”.
Poco dopo si aprì la grande stagione dei processi. Bisognava stabilire la verità su quello che era accaduto nel palazzo della Banca di piazza Fontana. “Inizialmente, le udienze dovevano celebrarsi a Milano. Ma il giudice esercitò quella che in latino si chiama ‘legitima suspicione’. In pratica, la città era considerata poco sicura ad ospitare il processo. Che, così, venne spostato al Sud, a Catanzaro”. Paolo, insieme alla sorella Francesca, non ha mai perso un’udienza. Ogni volta, arrivavano fino in Calabria per calcare quelle aule dove pretendevano giustizia per la morte del padre. “All’epoca, per viaggiare dalla Lombardia a Catanzaro ci volevano anche 22 ore di treno. Il giudice, guardando me e mia sorella così giovani, un giorno ci chiese perché ogni volta arrivavamo fino lì. Rispondemmo che facevamo tutti quegli oltre 1200 chilometri solo perché credevamo nella giustizia. E lui ci rispose così, in modo lapidario: ‘Cercheremo di fare del nostro meglio’”. Quelle per piazza Fontana sono state udienze monstre. Pile di documenti, migliaia di fogli scritti a mano contenenti prove, testimonianze, accuse. “Non c’erano computer o altro, era tutto cartaceo. Facendo un paragone, credo che possano essere stati tre tir pieni zeppi di documenti. Fu anche uno dei primi processi mediatici”. La sorella di Paolo, Francesca, più grandi di lui di sette anni, una volta ebbe anche il coraggio di rivolgersi direttamente agli imputati. “Erano Freda e Ventura. Lei li guardò e disse loro che sarebbe stata anche disposta a perdonarli, se solo avessero detto perché lo avevano fatto. E se fossero stati disposti a fermare quella scia di sangue”. Scia di sangue che, però, non si fermò. Perché pochi anni dopo ci furono Piazza della Loggia a Brescia, il treno ‘Italicus’, la bomba alla stazione di Bologna e il ‘Rapido 904’. Piazza Fontana era solo l’incipit. Piazza Fontana ha dato il via alla stagione delle stragi. Piazza Fontana è la madre di tutte le stragi.
Gli anni dei processi sono stati lunghi. “Circa trentacinque”, dice Paolo. “E non sono mancati i depistaggi, perché è certo che ci sono stati”. La parola fine alla vicenda giudiziaria sull’attentato alla Banca nazionale dell’Agricoltura l’ha messa una sentenza. “Quella del 3 maggio 2005. Una sentenza tombale, praticamente. La Cassazione ha confermato le responsabilità di Freda e Ventura per le bombe, ma non sono stati condannati perché erano stati già assolti per lo stesso reato nel 1987”. ‘Ne bis in idem’, direbbero i giuristi cultori del latino. Un esito paradossale, contradditorio. E la storia processuale, diversa da quella storica, si è chiusa così, senza colpevoli dichiarati. “Siamo stati noi familiari a dover pagare le spese processuali. Fortunatamente lo Stato ci ha aiutati. Ma è una sensazione terribile. È come se tu, vittima, fossi il vero condannato all’ergastolo”. Dopo la ‘sentenza tombale’ del 2005, è nata l’associazione dei familiari delle vittime di piazza Fontana. Prima a volerla è stata la sorella di Paolo, Francesca. “È sorta perché dovevamo far conoscere piazza Fontana, soprattutto nelle scuole, soprattutto alle nuove generazioni che spesso ne sanno pochissimo o non ne sanno nulla”, dice Paolo. Ogni anno, il 12 dicembre, i familiari si ritrovano per coltivare la memoria. E lo fanno attraverso un lungo corteo, commosso e silenzioso, che parte da piazza della Scala fino ad arrivare a piazza Fontana. “Partiamo da lì perché proprio a piazza della Scala, quello stesso giorno, era stata piazzata un’altra bomba, poi rimasta fortunatamente inesplosa”. Francesca Dendena si è sempre battuta per l’associazione. Tanto da ricevere, nel tempo, riconoscimenti e onorificenze, anche dalla presidenza della Repubblica. Il suo altissimo impegno civile è durato fino alla sua morte, nel 2010. Oggi il suo nome campeggia nel famedio del cimitero di Milano. Il suo testimone è stato raccolto dal nipote Matteo, figlio di Paolo, che sulla strage ha scritto un libro, trasformato in una docu-fiction di successo della Rai, andata in onda in occasione del cinquantenario. “Cosa lascia oggi piazza Fontana? Una delle stagioni più buie, dolorose e sanguinose per il nostro Paese”, dice Paolo. “Anche lo Stato dovrebbe chiedersi cosa è successo il 12 dicembre 1969. E dovrebbe dire perché non è stato in grado di fermare quello che è accaduto”. (di Marco Di Vincenzo) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)